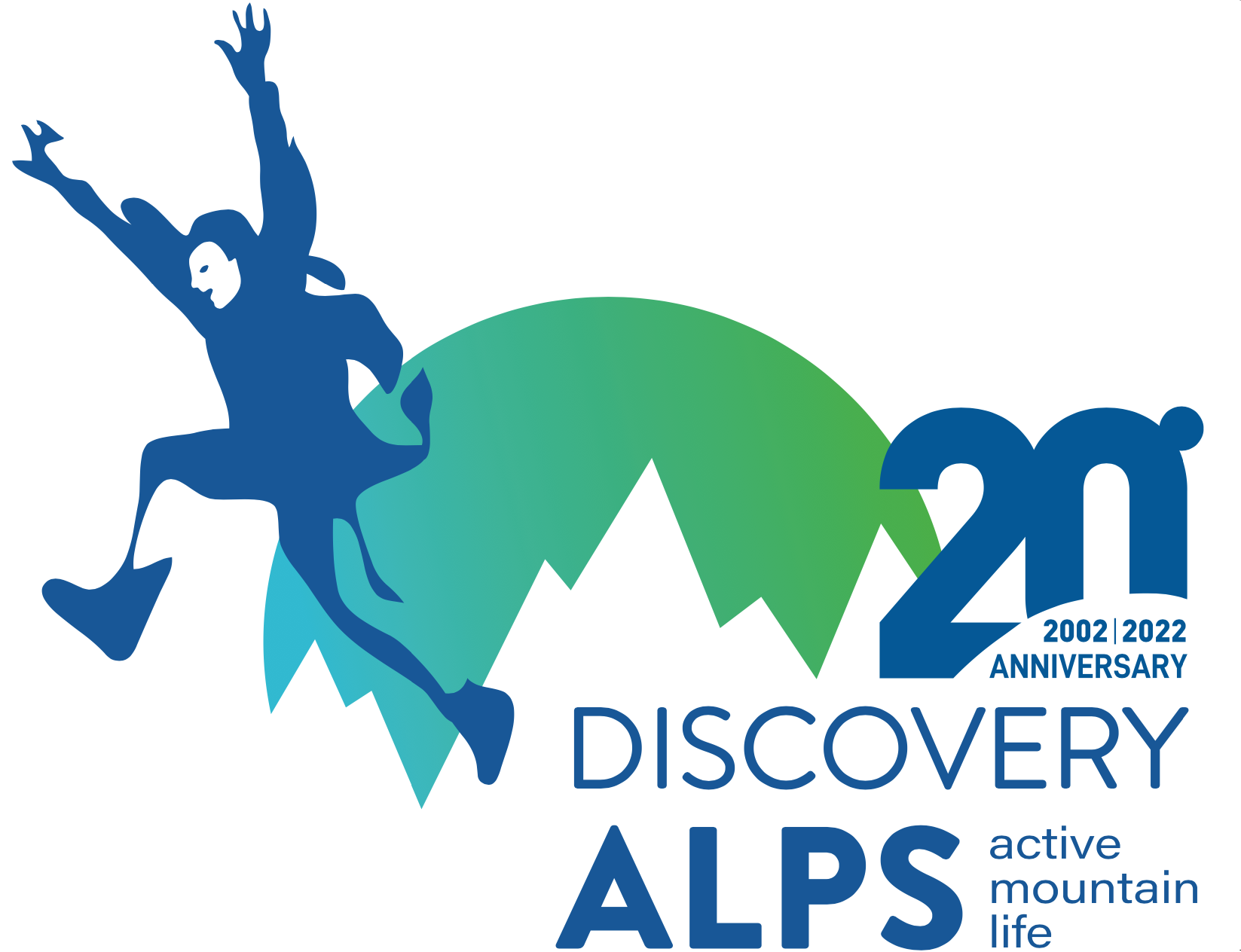L'11 ottobre 2013, a Macugnaga Monte Rosa scendeva la prima neve. Alcuni centimetri, sufficienti ad imbiancare il piccolo Dorf alpino. L'amica Beba Schranz decise allora di prendere un po' di questa neve e di portarla in un contenitore refrigerato fino a Milano. Qui la pose nelle mani di Rolly Marchi per consentirgli di salutare, per l'ultima volta, la "Buona Neve".
Oggi, 14 ottobre 2014, sulle Alpi la neve non è caduta, anzi splende il sole dopo giorni di intensa pioggia.
Oggi, 14 ottobre 2014, ad un anno dalla sua scomparsa, ricordiamo il giornalista, l'uomo, lo scrittore, l'alpinista, l'amico, lo sportivo Rolly Marchi, pubblicando un racconto che egli aveva dedicato a sua madre alcuni anni or sono.
"… Poi fiorisce la primavera. Mia madre sta per raggiungere in ottima salute uno straordinario traguardo, quello dei novantasei anni. Io, come ho già scritto, sono il suo unico figlio, convinto di esserle stato devoto soprattutto nello scorrere del tempo, felice di aver sempre sentito lei come punto di riferimento, di amore caldo e aperto, nei momenti di giubilo ma anche nei molti altri del dubbio, della malinconia, di un dolore, fisico o spirituale: sempre.
Anche a cinquant'anni, anche a sessanta, mai mi sono sentito a disagio mostrandomi, rispetto a lei, bambino.
Ho girato molto per la terra, passando dalle folle degli stadi alla solitudine di una montagna, dall'ebbrezza di una discesa con gli sci ai tremori e al silenzio della paura fra le rocce, dai rischi e dal terrore della guerra alla gioia immensa di esserne sopravvissuto. La mamma sempre lì, vero angelo custode, come avessimo camminato assieme lungo una strada diritta senza fine. Talvolta lei davanti,luce che mi guidava, qualche altra affiancati con la voglia di andare, frugando nell'aria e nei sentimenti. Lei, il mio continuo salvagente, perché una forza misteriosa e forse inesprimibile mi legava alla sua pelle, al suo cuore.
Dopo la morte di mio padre e dello zio di Centa questo rapporto si è fatto più vivido mentre l'immaginaria nostra strada è diventata più intima, più segreta. Anche più deserta, tutta per noi due che vi camminiamo, magari più lenti e un po' stanchi, ma con il passo ugualmente affettuoso.
Un giorno di alcuni anni orsono avvertii che il suo bisogno della mia presenza era accresciuto, anche perché a novant'anni amici della stessa età ne rimangono ben pochi. E allora, ovunque mi trovassi, cominciai a telefonarle ogni sera per dirle che stavo bene, per augurarle la buona notte e anche , naturalmente, per sentire il calore della sue voce.
Al suo "pronto" la delineavo nell'aria, la sentivo sorridere ed ero contento. Così ogni sera, sempre.
Se la chiamo da Milano, o da Cortina, o comunque dall'Italia, mi lascia parlare, mi chiede del lavoro, della salute, dei figli. Quando vado a trovarla le piace elencarmi nomi di amici premurosi che sono andati a visitarla, con biscotti, fiori o una torta, i Pasquazzo, Soldà, Agnoli, Munerati, Pizzini, Moggio, Tommasini, la Marcella, l'Halina, la Rosa, la Pia… Se li è scritti su un foglio e me li elenca, non vuole dimenticarne nemmeno uno perché poi sarà mio compito e dovere ringraziarli.
Quando invece sono all'estero, le basta un saluto. Nel 1988 ero in Corea per le Olimpiadi e dopo la seconda telefonata, con la sua voce che si inteneriva come sicuramente la luce degli occhi, mi disse di non chiamarla tutte le sere, che bastava anche ogni tre giorni, "chissà cosa costa da così lontano…". La vedevo mentre mi parlava con il suo viso di amore per tutti, inabile a essere cattiva, e anche dopo, quando avrebbe detto ai visitatori che il suo Rolando era alle Olimpiadi e che le aveva telefonato. "Dalla Corea!".
L'ultimo inverno è stata bene fino mal mese di febbraio, quando ero in Norvegia per le Olimpiadi. Appena tornato sono andato a trovarla, lei e sua sorella Elena, mia unica e amata zia che invecchia bene e mangia con appetito anche se in bocca le sono rimasti soltanto due denti e nel fisico appare sempre più fragile.
Conviventi da quindici anni, ugualmente contente di vedermi, sempre un po' più del solito quando torno da un volo da lontano. Ma quel giorno mia madre non diffondeva la consueta emozione, il suo sorriso era più languido, meno partecipe, come se una nebbia improvvisa si fosse diffusa nel buio della notte penalizzandole il bagliore degli occhi: "Qualcosa non va, non so cosa sia ma non sto bene, non ho più voglia di mangiare". E con una mano si accarezzò lo stomaco.
Sono rimasto con lei tre giorni senza riuscire a galvanizzarla, la guardavo, il suo abituale calore era diventato impenetrabile. Stava seduta nel divano, non le interessava la amica televisione, mi fissava con un ombra di inquietudine, o di solitudine. Per la prima volta nella vita ho sentito che per lei non potevo far nulla. Nemmeno il suo medico, il devoto Marcello, che non riusciva a capire.
Dovetti ripartire, le telefonavo più volte al giorno, continuavo a non sentire quel fremito di una remota volontà. E una sera, dopo averle detto "ciao mamma, sono io", aspettai la sua voce. Niente. Un silenzio inquietante, poi improvvisamente le voci allarmate di zia e della Pia che la incitavano a dirmi qualcosa, "c'è il suo Rolando…gli parli", insisteva la buona Pia. Niente, una quiete mortale.
Sono salito in auto, era scarso il cosiddetto traffico, mi teneva compagnia la luna piena che illuminava di argento l'autostrada come fosse stata un placido fiume e correvo continuando a pensare a lei, che non mi aveva parlato. Niente. Dopo due ore ero a Trento, ma la casa era vuota, inquietante. Sul tavolo della cucina un biglietto con la diligente calligrafia della zia: "siamo a Villa Bianca".
La mamma stava in una stanza in penombra, supina, immobile. Mi sentì, sussurrò "che bravo, sei venuto subito, ma chissà come hai corso, sta attento che è pericoloso". Mi avvicinai e la baciai, cercava di sorridermi ma per la prima volta nella vita non potevo fare a meno di pensare che fosse prossima alla fine. Il sorriso infatti non si era diffuso sull'intero volto.
Nella sua immobilità leggevo il peso di una vita lunghissima che aveva sofferto le tempeste di due guerre mondiali e le molte amarezze che sono seme e vento di ogni tempo e luogo. La zia e la Pia mi lasciarono solo, il dottor Marcello si offrì di accompagnarle con la sua auto, io me ne andai dopo, con il consenso dei medici, la mamma era assistita e a casa mi aspettava la zia, stanca di pensare e di soffrire e incapace di dormire prima del mio ritorno. La luna aveva attraversato il cielo e stava immobile sopra le creste nere del monte Bondone. Era una bella notte.
Il mattino seguente, mentre bevevo il caffè, sul balcone planò un uccello, il merlo che si affacciava ogni giorno a beccare briciole di pane, pezzetti di frutta, riso, i cibi che mia madre gli preparava da qualche anno. Saltellava avanti e indietro, si arrestava e mi guardava con un fuggevole scintillio negli occhi-così mi pareva- deluso di non trovare i soliti alimenti. Lasciai passare qualche minuto, poi aprii la porta e gli sbriciolai un biscotto mentre lui si era allontanato sul fondo del balcone. Mi guardava fermo e diffidente, si riavvicinò a beccare soltanto dopo che ero rientrato e avevo richiuso la porta.
Tornai in clinica, mamma stava peggio, era più isolata, assente. I dottori non erano ancora riusciti a capire esattamente cosa l'avesse colpita però erano certi che il suo straordinario motore facesse uno sforzo tremendo a non arrendersi. In serata fu convocato un consulto e dopo un ora tre uomini in camice bianco mi dicevano che se non fosse stata operata subito non sarebbe vissuta più di un giorno. "naturalmente alla sua età le possibilità che resista all'intervento non sono molte, l'anestesia…lei è il figlio, sta a lei decidere", mi disse con esemplare freddezza il chirurgo dottor Eccher, conosciuto come molto bravo.
"Se il figlio fosse lei, cosa direbbe?", gli domandai anche se avevo già pensato che di fronte a una morte certa non avrei dovuto esitare.
"Direi di si".
Era notte ormai, presi il cappotto e il cappello, e con passo incerto e infelice uscii per bere un caffè. Tornai presto nella clinica ormai deserta, mi sedetti nella penombra del corridoio d'ingresso ad aspettare. Non mi sono mai sentito così solo e così addosso al suo viso che vedevo dappertutto in un silenzio tormentoso. Soltanto il tic-tac di un orologio a parete, tic..tac..tic..tac, una compagnia spietata.
Dopo circa due ore uno dei tre uomini bianchi – immagine spettrale – apparve sul fondo semibuio. Mi alzai. Quando mi fu vicino – era l'anestesista dottor Zeni -il suo viso si illuminò quanto bastava per dirmi che mia madre era viva. Gli strinsi una mano, lo ringraziai.
Era stata colpita da una peritonite, rarissima a novantasei anni:" devo dire che all'intervento ha resistito bene, ma il recupero sarà comunque faticoso".
Verso mezzanotte la rividi nel suo letto, con flebo, una sonda nel naso e altre che uscivano dai bordi delle coperte come tentacoli di un polipo. Il suo respiro era un rantolo lento e ritmato. Immagine durissima, una statua di cera in una stanza desolata.
Il chirurgo, passato per un controllo, mi diceva che potevo rincasare, di stare tranquillo, almeno per quella notte. Ma alle prime luci del nuovo giorno ero lì. Aprii la porta timoroso, non era cambiato nulla. Lei avvertì il mio passo, anche se felpato, sollevò faticosamente le palpebre e cercò di girare il capo per arricchirmi di un debolissimo sorriso. Appena percettibile, ma sorriso era. Incredulo, le sfiorai una guancia con la mia bocca, la baciai, poi spostai una sedia per starle vicino, con una sua mano avvolta dalla mai. Non potevo far niente, la guardavo, sentivo un nodo allo stomaco, pensavo alla fatica del suo cuore a tenerla viva. Ma era vita, in quel modo artificioso?
Vennero i dottori, sorpresi della sua tempra. Riuscì a dir loro grazie, anche se probabilmente non capiva cosa era avvenuto. Vidi che voleva parlare, avvicinai il mio viso alla sua bocca, "come sei bravo a stare sempre qui".
Non avevo mai seguito un moribondo in un letto, faticavo a capirla, ogni parola le pesava. Dopo tre giorni però era migliorata, almeno in apparenza. Viveva di flebo, le bagnavo le labbra, mi chiedeva dei miei figli, di Graziella, e ringraziava.
Mi venne un'idea. Al festival di San Remo mi aveva commosso la canzone vincitrice, uno straordinario atto di amore per tutte le mamme cantata dal giovane Luca Barbarossa. Un capolavoro? Non l'avevo ancora pensato, m in quel momento si: "mamma portami a ballare…portami a ballare…uno di quei balli antichi che non si fanno più…sciogli i tuoi capelli…lasciali volare…lasciali girare forte intorno a noi…".
Quando verso le undici si è affacciata una sua fedele amica, la cara Marisa, l'ho pregata di trattenersi e sono andato a comperare la cassetta e un piccolo stereo e quando siamo stati nuovamente noi due soli, ho premuto il pulsante: "Mamma ascolta". Dopo le prime melodie ha cercato di stringermi la mano con tutta la poca energia che ancora aveva e forzava le palpebre per guardarmi: "che bravo ragazzo quel cantante…deve proprio voler bene a sua mamma quel cantante…lo conosci? Che bravo…".
Il giorno dopo, uscito di casa, ecco il merlo, fermo davanti alla porta. Sul balcone non aveva trovato più niente, mi guardava, aveva capito che qualche cosa era cambiato. Zampettò, mi seguì con dei voletti verso la macchina, continuò a guardarmi fino a quando accesi il motore e mi avviai.
Mamma teneva duro, non migliorava né peggiorava, era, come si dice, stazionaria.
"Stai proprio meglio", le mentii.
"Abbastanza", sussurrò mentre il primo raggio di sole trafiggeva l'unica finestra.
"Allora adesso mi dai un bacino".
"Uno? Due", borbottò riaccendendosi al sorriso. Due, sono stati gli ultimi.
In serata ho avuto la sensazione che le sue mani fossero fredde, che quasi non fossero più sue, il respiro era più faticoso. Decisi di dormirle accanto e improvvisamente mi sono risentito bambino, come quando avevo già la mia stanza ma ero felice se per premiarmi, o soltanto per farmi contento, mi prendeva a dormire nel suo letto, fra lei e papà. Un bambino di settant'anni, adesso.
Naturalmente ho dormito poco, quasi niente, ascoltavo il suo respiro, la guardavo, ma nella luce fioca la vedevo appena. All'alba, nella quiete ancora diffusa, molto prima che arrivasse il dottore con le infermiere, le ho suonato ancora il nostro inno: "lasciati guardare, lasciati guardare/sei così bella che non riesco più a parlare/di fronte a quei tuoi occhi perfino il tempo si è fermato…parlami di te, di quello che facevi/se era proprio questa, la vita che volevi/di come ti vestivi, di come ti pettinavi…dai mamma dai/questa sera siamo qua…". Che fatica, che piacere, che pena!
La sua agonia è durata diciannove giorni, poi, alle tre di un pomeriggio, il cuore si è fermato. Ero purtroppo assente in quell'attimo, la sua resa mi è stata telefonata. Per un momento mi sono smarrito, e mi sono anche sentito in colpa ma più tardi no, perché quando sono arrivato in clinica non aveva più i tubi e le cannelle, era già stata ricomposta e vestita con uno dei suoi abiti preferiti, blu con dei fiorellini di monte attorno al collo. Bellissima, con i lineamenti distesi e la grande calma che assumono normalmente i morti.
Gli amici che erano già lì sono subito usciti per lasciarmi solo nella stanza bianca che mi parve disadorna come una piccola prigione, la tenda immobile, l'aria nera, non una fotografia dei nonni, di mio padre, non un fiore, ancora. E dal pavimento lucido si espandevano odori di profumo, o di disinfettante, che mi negavano il profumo del suo corpo che volevo respirare per l'ultima volta, unico suo bene che avrei potuto sentire ancora per qualche momento. Con qualche lacrima sulla guance l'ho baciata, accarezzata,poi, in tono basso perché non si sentisse in corridoio, ho premuto il pulsante per l'ultima volta, "sei così bella, che non riesco più a parlare…dai mamma, dai…". Piangevo, con la testa china, sentivo un senso di male in tutto il corpo e qualche improvviso rimorso.
Due giorni dopo l'abbiamo sepolta nel paese dove era nata. Per delle leggi un po' stupide che ignoravo non è stato possibile metterla nella terra accanto a mio padre, a Lavis, perché "la tomba era troppo vecchia, o non avevo rinnovato in tempo una domanda", qualcosa di simile. Ma anche la terra di Centa andava bene, c'erano suo padre e sua madre, i fratelli, e l'aria, il sole, il vento, la pioggia e i fiori della sua giovinezza.
Dopo il funerale, salutati gli amici e conoscenti, mentre guidavo sulla strada verso Trento, mi sentivo molto solo anche se in auto eravamo in quattro. Vedevo scorrere nell'aria il film della nostra vita, settant'anni, che non sono pochi. E per la prima volta ho capito l'importanza e la forza di quei venticinque anni che ci dividevano, una riserva di tempo che mi avevano sempre illuso come e più di una buona pensione per la mia vecchiaia. Invece, mentre procedevo lungo le molte curve di Vattaro e Valsorda, vedevo maturare la convinzione che alla vecchiaia mi dovevo tristemente abituare. E che ogni futuro ritorno a Trento sarebbe stato diverso.
Arrivai in città, davanti a casa c'era il merlo. Stava di fianco alla porta, in attesa, fermo. Vedendolo così fedele e a modo suo partecipe al lutto ebbi un attimo di agghiacciante piacere. Non solo gli uomini, anche un uccello sapeva della grandezza di mia madre.
Prima di aprire la porta, emozionato, ho rivisto quella lunga strada, diritta e infinita, sulla quale lei e io avevamo sempre camminato assieme e bruscamente mi sono sentito in prima linea, solo davanti a tutto. Con fatica ho riordinato i sentimenti, ho guardato verso l'alto il giroscale e ho fatto un respiro profondo. Ai primi passi mi sono reso conto che il mio ritmo era diventato più lento e più greve, e quella strada in salita. C'era anche un tunnel buio sul fondo, un tratto inesplorato del mio destino. Stavo andando incontro a una vita diversa e guardavo laggiù, laggiù,in un silenzio da brividi. Fino dove? Fino a quando?".